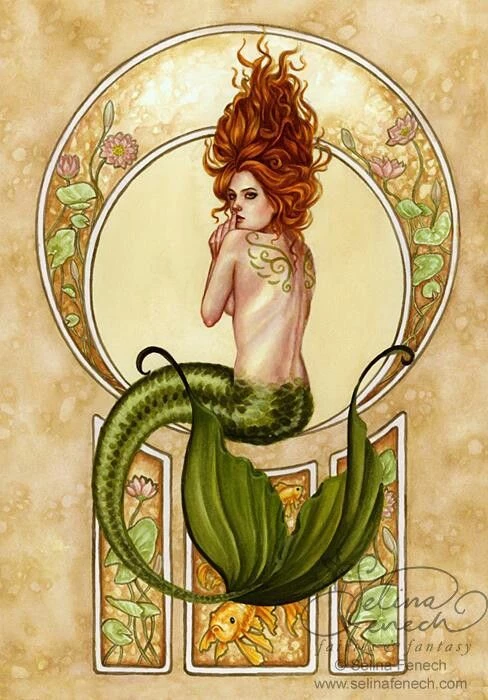
‘Il caso delle sirene. Per Omero questo mostro di natura era un collage di donna e di uccello, e così ce le descrive nell’Odissea. Più tardi, Orazio allude alle sirene ma come innesto, ben più noto, di una donna e di un pesce. Nel Fisiologo, opera scritta nei primi secoli dell’era cristiana, la sirena ha per metà corpo muliebre e per metà corpo d’oca. Qualche secolo più tardi, all’ombra del Mille, su un altro bestiario, Liber Monstruorum, la coda della sirena subisce un’altra metamorfosi zoologica, e torna a farsi squama, e pinna natante. Tutte chirurgie, e trapianti, fantastici, che dimostrano l’instabilità dell’immagine mentale, incerta tra il pesce e l’uccello.’ (Giorgio Celli)
Sirene: creature che non appartengono alla Terra, ma all’Aria (metà donne metà uccelli) o all’Acqua (metà donne metà pesci). Le leggende che hanno per protagoniste le sirene risalgono alla notte dei tempi: la prima di cui siamo a conoscenza è Atargatis, una divinità originaria della Mesopotamia il cui culto si diffuse per tutto il Mediterraneo, fino alla Grecia e all’antica Roma. Già nell’Età del Bronzo erano venerate diverse divinità ittiche, essendo i pesci e l’acqua simboli di fertilità e di abbondanza. La dea Atargatis era dunque garante della ricchezza del suo popolo, oltre a incarnare i valori della protezione e dell’ordine sociale. Sorge a Hierapolis un tempio a lei dedicato. Secondo una leggenda, inizialmente era una donna, innamorata del dio della comunità, Hadad. Quando costui morì in circostanze tragiche, la donna, per disperazione, si tuffò negli abissi, e qui avvenne la sua metamorfosi in sirena, che la legò per sempre al suo popolo, divenendo di fatto parte di quel mondo acquatico che assicurava la sua fertilità e la sua abbondanza. Una volta entrata nel pàntheon dell’antica Grecia, la figura di Atargatis venne associata alla costellazione dei Pesci, i cui significati simbolici e religiosi concernevano la spiritualità, la dimensione onirica e il subconscio.

Se in ambito greco-romano Atargatis mantenne il suo status di dea protettrice e feconda (alcuni studiosi ipotizzano che Atagartis fosse solo un altro nome della grande Dea Madre Syria), le creature che noi oggi conosciamo come sirene costituivano invece per gli ellenici qualcosa di ben diverso. In Omero sono donne alate ingannatrici che facevano naufragare i marinai, esseri onniscienti dotati di misteriosi poteri, seducenti mostri la cui arma più letale era il canto. Quando Ulisse, nell’Odissea, si trova a passare accanto a loro (successivamente chiamate Leucosia, Partenope e Ligea), si fa legare dai compagni all’albero maestro per non cedere al pericoloso e irresistibile incanto della loro voce, e tuttavia non si tura le orecchie come gli altri marinai, perché quella voce ammaliante che promette la conoscenza Ulisse la vuole udire! Alle sirene, sconfitte dalla resistenza di Ulisse e dei suoi compagni d’avventura, non resta che suicidarsi, compiendo quello che in greco viene detto katapontismós (ossia ‘morte per acqua’).

Ma rimaniamo in Grecia, spostiamoci solamente nel tempo, pochi secoli dopo. Nel 412 a. C. (ricordiamo che l’Odissea fu scritta attorno all’VIII secolo a. C.) Euripide portò in scena la tragicommedia Elena, un’opera che scagionava la presunta amante di Paride il cui rapimento aveva provocato la guerra di Troia. Anche Euripide nominò le sirene, anch’egli fece riferimento al potere prodigioso del loro canto. Qui tuttavia la loro voce non era un’arma, bensì un balsamo che leniva le pene delle anime dei defunti. Poste da Euripide davanti alle porte dell’Ade, egli fece di loro delle creature crepuscolari e consolatorie, che addolcivano ai trapassati il soggiorno nell’Oltretomba. Un’altra leggenda dell’antica Grecia avente come protagoniste (o, meglio, come antagoniste) le sirene è presente nel poema Le Argonautiche di Apollonio Rodio, risalente al III sec. a. C.. Qui, Giasone e gli Argonauti riuscirono a sfuggire alle mortifere incantatrici grazie a Orfeo e alla sua musica. E’ soltanto in questo poema che abbiamo la prima vera descrizione dell’aspetto delle sirene (nell’Odissea Omero non aveva accennato in alcuna maniera alle loro fattezze, il che farebbe pensare che alla sua epoca si trattasse di creature ben note ai suoi lettori, e confermerebbe le loro antichissime origini): Apollonio Rodio invece si sofferma sulle loro sembianze, e le definisce creature metà umane metà uccelli dotate di affilati artigli. Pare ormai confermato che la loro metamorfosi in donne dotate di una coda di pesce sia avvenuta nel Medioevo, e più precisamente intorno al II secolo d. C.

Scrive Elisabetta Moro, Professore Ordinario di Antropologia Culturale e docente di Mitologie contemporanee: ‘Il corpo delle sirene ha cambiato forma gradualmente e più volte. Non sappiamo esattamente come sia accaduto, ma sappiamo che è successo. Il loro polimorfismo le ha rese compatibili e adattabili a molti contesti e significati diversi, passando da una connotazione negativa, legata al pericolo, a quella attuale, che le ritrae come esseri affascinanti, niente affatto temuti. Passando per una fase intermedia dominata dal tema del corpo seduttivo. Come se per continuare il mito dell’attrazione fatale la voce non fosse più sufficiente e necessitasse di nuove ragioni di plausibilità. Si giunge così all’idea di una sirena più seduttiva anche nel corpo.‘
Quel che è certo è che, durante il Medioevo, la Chiesa vide nella figura della sirena qualcosa di mostruoso e di diabolico: in fondo si trattava di una creatura non umana (non interamente, almeno), una donna dotata del potere della seduzione, della tentazione che porta gli uomini alla rovina, una sorta di strega che ammaliava le sue vittime con la propria lussuria e impudicizia, simbolo di perdizione e di vanità (non era raro che le sirene venissero raffigurate nell’atto di pettinarsi i lunghissimi capelli guardandosi allo specchio). Un altro aspetto da non trascurare: sebbene le sirene appaiano nei miti e nel folklore di quasi tutte le culture e religioni (si possono trovare nelle leggende mediorientali, africane, etrusche, greco-romane, celtiche, russe, e addirittura dell’estremo Oriente), nella Bibbia non ne è rintracciabile nemmeno un accenno. Eppure si tratta di figure primordiali, ataviche, forse addirittura archetipi dell’inconscio collettivo di cui parlava Jung. Perfino l’etimologia del termine sirena è avvolta nel mistero. Scrive a tal proposito Euterpes Domus nel suo blog EtimologicaMente: ‘Per quanto riguarda (…) l’etimologia della parola “sirena”, essa deriva dal termine greco Σειρήν, “Seirḗn” (plurale Σειρῆνες, “seirênes”), di incerta origine. Taluni hanno avanzato l’ipotesi che il termine vada ricollegato all’aggettivo σείριος, “séirios” (splendente, ardente, da cui anche Sirio —> cfr. sanscrito “Sūrya”, sole), che farebbe quindi delle sirene degli spiriti o dei demoni di mezzogiorno (l’ora più calda e quando il sole splende di più, appunto). Altri legano il termine a σειρά, “seirà” (“corda”, “fune”), riprendendo il fatto che le sirene “legano” a sé i naviganti e li irretiscono. Infine, l’ipotesi più semplice si basa su un origine semitica dal verbo “sir”, “cantare”.‘

Se facciamo un tuffo nel folklore celtico, troveremo un sacco di leggende sulle sirene. Prendiamo ad esempio la sirena di Zennor. In Cornovaglia esiste questo piccolo villaggio, Zennor appunto, in cui si trova una chiesa che conserva la sedia della sirenetta, un sedile in legno con una sirena intagliata lateralmente. Secondo un’antica leggenda, ogni domenica una sconosciuta fanciulla si recava alla Messa per ascoltare il canto di un giovane corista. Costui, affascinato dalla ragazza, decise un giorno di seguirla fino a un torrente, da cui non fece più ritorno. Pare quindi che la sconosciuta fosse una creatura marina, e che per amore il corista abbia abbandonato la propria vita terrena per unirsi all’universo degli abissi. Nella Mermaid’s Cove (così venne in seguito chiamata la parte meridionale del paese) si racconta che ancora oggi si possano udire le voci dei due amanti unite in un canto melodioso e magico. Spostandoci in Irlanda possiamo fare la conoscenza di Lí Bán, donna bellissima la cui storia viene narrata addirittura negli Annali dei Quattro Maestri (cronaca medievale della storia irlandese). Principessa dell’Ulster, fu, insieme al suo cane, l’unica a sopravvivere quando la sua casa venne inondata. Dopo un anno di dolorosa solitudine, ottenne dagli dèi la possibilità di diventare una sirena, per condividere la sua vita col popolo marino; anche il suo adorato cane, trasformato in lontra, poté così continuare a starle accanto. Ribattezzata Muirgen, fu fatta santa e patrona delle sirene. La sua festa cade il 27 gennaio.

Per rimanere in ambito celtico, non si può non nominare Ceasg, la celebre sirena dalla coda di salmone che viveva nel mare della Scozia e che, se catturata, poteva esaudire tre desideri espressi proprio da chi l’aveva fatta prigioniera. Si racconta che si unisse spesso carnalmente a esseri umani, concependo numerosi figli, ma portando poi alla morte i suoi sventurati amanti e le loro eventuali mogli. Secondo lo studioso di folklore Donald MacKenzie, Ceasg era originariamente una dea del mare a cui venivano offerti sacrifici umani. Le Morfowynion sono invece le sirene del Galles, personificazioni delle onde pericolose. Di colore brunito, hanno un volto mostruoso, senza mento né orecchie, braccia corte e mani palmate.

Passiamo ora alle leggende e ai miti germanici. Se nel folklore celtico le sirene alternavano caratteristiche benigne a nature perverse, per i tedeschi esse sono senz’ombra di dubbio creature malvagie. Chiamate Nixes, vivono in uno splendido castello situato nelle profondità dei laghi o dei fiumi, e possono mescolarsi agli umani rendendosi invisibili oppure trasformandosi in splendide fanciulle o vecchie megere. Dotate di poteri profetici, sono facilmente smascherate se viene suonata della musica, poiché in questo caso non riescono a trattenersi dal danzare. Alcune leggende le vedono protagoniste di rapimenti di bambini o di inganni tesi a portare gli umani ad annegare. In Norvegia la sirena è detta Havfrue, e descritta come maligna e vendicativa. Non solo: secondo alcune fonti sono anche apportatrici di sventura (da qui l’usanza dei marinai di scolpire sulla prua delle loro navi una polena, il cui compito sarebbe di ingraziarsele). Le sirene scandinave inoltre sono caratterizzate da un aspetto ambiguo; in apparenza il loro viso è grazioso e gentile, ma in realtà possiedono denti affilati e taglienti. Infine, non dobbiamo dimenticare che anche la nostra bellissima penisola è ricca di leggende riguardanti queste affascinanti e pericolose abitanti dei mari. Ne riporterò qui una, forse la più famosa, esattamente come l’ho trovata sul sito Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico:
‘La leggenda narra che quando Taranto era la capitale della Magna Grecia, ed essendo bagnata da due mari, divenne meta preferita delle sirene che decisero di risiederci in modo stabile costruendoci il loro castello incantato. In quell’epoca viveva a Taranto una coppia di sposi, lei bellissima, lui un imponente pescatore. A causa del suo mestiere il giovane pescatore era costretto a star fuori dalla propria città tutto il giorno e a volte anche svariati giorni. La bellezza di lei fu notata da un ricco signore il quale cominciò a provare interesse per la sposa solitaria e approfittando della mancanza del marito incominciò a corteggiarla. Con il passare del tempo riuscì un giorno a sedurla. La sposa preda del rimorso, confessò tutto al marito, il quale la condusse con una barca in alto mare e la spinse in acqua facendola annegare. Le sirene arrivarono in suo soccorso appena in tempo, ed essendo ammaliate dalla sua bellezza la proclamarono loro regina, dandole il nome di Schiuma (Skuma), perché condotta dalle onde. Nel frattempo, il pescatore si pentì del suo gesto e pensandola morta, tornò più volte nel punto in cui la giovane moglie era affogata, piangendo ore e ore.Le sirene incuriosite dal suo comportamento decisero di impadronirsi della sua barca facendolo cadere in acqua. Lo condussero al castello incantato per far decidere alla regina cosa farne. Skuma lo riconobbe è pregò le sue amiche sirene di non fargli del male. Così lo ricondussero svenuto sulla riva lasciandolo li fino al mattino. Quando il pescatore si risvegliò capì che la sua sposa non era morta è capì che nulla era più importante che ricongiungersi alla sua sposa. Così si rivolse a una giovane fata, che gli svelò il modo per liberare la sua dolce sposa cogliendo l’unico fiore di corallo bianco dal giardino delle sirene. Il giorno successivo il pescatore si procurò un’altra barca e arrivato in alto mare, iniziò ad urlare il nome della moglie. Skuma a questo punto fuggì dal castello e riuscì a riabbracciare il giovane pescatore. Prima di lasciarla ritornare dalle sirene, il pescatore riferì a Skuma il modo per poterla liberare e cioè quello di prendere l’unico fiore di corallo bianco dal giardino delle sirene. Così Skuma elaborò un piano da effettuare il mattino seguente. Il pescatore usò tutti i risparmi per comprare bellissimi gioielli, li mise in barca e si addentrò nel golfo di Taranto. Le sirene lasciarono incustodito il castello perché ingolosite da gemme e pietre preziose. Così Skuma riuscì a rubare il fiore di corallo ed a consegnarlo alla fata che la attendeva sulla riva, la quale fece alzare una grossa onda che spazzò via tutte le sirene. Purtroppo, il pescatore non fece in tempo ad allontanarsi e fu travolto dalla stessa onda. Skuma, rimasta sola decise di prendere i voti e divenire monaca. La tradizione popolare vuole che, da quel giorno, nelle notti di plenilunio, Skuma, vestita da monaca, si aggiri per il Golfo di Taranto sperando nel ritorno dell’amato. Da questa leggenda, deriverebbe il nome di una delle Torri abbattute del Castello Aragonese, quella detta, “Torre della Monacella”.’

Anche i paesi slavi hanno le loro sirene. In Polonia si racconta di come una di queste creature protegga la città di Varsavia, dove una statua la ritrae in Piazza Vecchia con la spada sguainata e lo scudo per difendersi. La leggenda che la riguarda riporta che inizialmente i marinai le erano ostili, poiché ogni notte essa liberava dalle reti i pesci da loro catturati. Ma ben presto, udendone il canto ammaliante, si innamorarono tutti di lei, e quando un bieco impresario la imprigionò per trasformarla in un’attrazione da circo i marinai corsero a liberarla. E fu così che la sirena, per ringraziare i suoi salvatori, giurò che per l’eternità avrebbe protetto la loro città. I russi hanno le Rusalki, o le Beregine; i bulgari hanno le Samovile, e i serbi e i croati le Vile. Queste creature erano demoni femminili che vivevano nei fiumi e nei laghi, e, a seconda dei paesi in cui furono tramandate le loro gesta, potevano essere malvagie e pericolose, e ingannare gli uomini per farli annegare, oppure tormentati spiriti di giovani donne suicide o uccise dai loro amanti per poi essere gettate nelle acque.

Sempre nella mitologia slava esiste anche una variante al maschile della sirena: si tratta del Vodyanoy. Costui attraversava i fiumi su un tronco d’albero e trascinava sott’acqua chi aveva la sventura di incrociarlo. Contrariamente alle sirene, non possedeva un aspetto affascinante; si presentava anzi sotto le sembianze di un vecchio, con lunghi capelli e barba verdastri, e il corpo squamoso, ricoperto di alghe e fango. Le sue mani erano palmate, e al posto delle gambe aveva anch’esso una lunga coda di pesce.

Ma lasciamoci ora l’Europa alle spalle, e trasferiamoci in Oriente. Il poema epico Ramayana è uno dei testi più importanti dell’Induismo, e narra della lotta tra Rama (settimo avatara di Visnù) e Ravana, perfido demone colpevole di aver rapito la sposa di Rama. Tra i guerrieri fedeli a Rama c’è anche un certo Hanuman. Ebbene, è proprio a questo punto che entra in scena una sirena, addirittura una principessa sirena. Il suo nome è Suvannamaccha, e il suo malvagio proposito è quello di rovinare i piani di Hanuman, ma nel compiere la sua missione se ne innamora follemente. Nonostante si tratti di un personaggio del Ramayana, Suvannamaccha è nota principalmente in Thailandia e in Cambogia. Nel folklore filippino, le sirene assomigliano quasi in tutto a quelle occidentali, l’unica variante è che, secondo le leggende che le vedono protagoniste, esse vengono spesso accompagnate da verdi umanoidi ricoperti di squame, dotati di pinne e di arti palmati, chiamati Siyokov. In Cina si dice che le lacrime delle sirene si trasformano in perle, e in Giappone sono apportatrici di sventure e naufragi se catturate da esseri umani; queste creature (Ningyo, in giapponese), che in comune con le sirene occidentali hanno la voce ammaliante e flautata, possiedono però lineamenti bizzarri, in quanto la loro bocca è simile a quella delle scimmie.

Nella cultura africana, la sirena è una vera e propria divinità. Il suo nome è Mami Wata, e le origini del suo mito sono piuttosto complesse, poiché vi si mescolano credenze indigene e tradizioni portate da popoli stranieri. Scrive l’archeologa Arianna Santini: ‘Divinità delle acque marine, Mami Wata si manifesta come una sirena e il suo culto abbraccia alcuni stati costieri che si affacciano sul Golfo di Guinea. Le sue prerogative sono principalmente legate alla fertilità e a tutto ciò che riguarda il mondo dello spirito e del corpo femminile. Questa divina sirena dimora sul fondo del mare, in una città bella oltre l’immaginabile; è possibile incontrarla e vivere in tale posto, ma ciò ha un costo e questo è la morte. Solo in questo modo è possibile “vivere” negli abissi più profondi. Chi decide di non vivere insieme a lei nel suo palazzo sottomarino torna nel suo mondo coi vestiti completamente asciutti e con un nuovo bagaglio di consapevolezza, più belli e addirittura più ricchi, sintomi del superamento di una prova che li ha fatti tornare cambiati, nell’ottica di un’iniziazione. La morte, vera o rituale, è la condizione necessaria a raggiungere un punto più elevato dell’esistenza, la vicinanza alla divinità e al mondo del sovrannaturale. Mami Wata è una dea “polifunzionale”, è aperta alla stipulazione di patti e racchiude in sé molti dei difetti solitamente attribuiti alle donne dalle varie società di appartenenza: vanità, avidità e attaccamento al denaro, gelosia, libertinismo e ambiguità, talvolta si presenta anche in forma maschile, prepotenza e irascibilità. Durante la grande stagione di importazione di umani dall’Africa all’America, a partire dal 12 Gennaio 1510 (lo sappiamo perché è in questa data che il governo francese ufficializzò la tratta, ma le navi negriere già erano cariche e partirono immediatamente), gli sfortunati viaggiatori forzati portarono con loro anche le divinità. Nel corso del tempo elaborarono che avrebbero potuto usare il loro potere come arma contro l’oppressore bianco e i suoi crimini (o almeno questo è ciò che, in un’accurata opera di propaganda antivoodoo, è stato fatto credere per demonizzare questa nuova cultura con antichissime radici e i suoi praticanti). Queste 18 tribù dell’Africa occidentale si unirono spiritualmente mettendo insieme le loro similitudini e diedero vita alla religione sincretica del Voodoo (più vicina di altre, dello stesso ceppo, alla cultura Africana del Golfo vera e propria). La loro fede era l’unica cosa che possedevano e ciò che li univa rendendoli forti della propria identità e rendeva i loro animi sempre pronti alla rivalsa. Nel 1685 però una legge del corpus del “Codice dei Negri” sancì la condizione d’illegalità della professione della propria religione, imponendo a queste persone il battesimo: chiunque non si fosse sottoposto a tale rito sarebbe stato imprigionato e spostato, separato dal proprio gruppo verso nuova destinazione. Nel caso in cui fosse stato un sacerdote a non convertirsi, sarebbe stato ucciso. Gli Africani non si arresero mai. Fin dalla prima generazione, presero a riunirsi sulle montagne per preservare la loro identità e capirono che l’unico modo per farla sopravvivere sarebbe stata mascherare le loro divinità da santi e funzionò. Come si inserisce Mami Wata in questo articolato schema di corrispondenze? Non è specificato con precisione e a mio avviso sarebbe inesatto limitare una forma divina inserendola in un parallelismo chiuso con un’altra. Sarebbe banale assimilarla ad una Gran Madre o una santa specifica; Mami Wata è Mami Wata col suo serpente attorno al collo e non per forza deve essere stata rielaborata in un’accezione positiva per essere “accettata” dai bianchi. Tale dea è stata assimilita ad una serva del Diavolo e la religione cattolica non ha mai rifiutato l’esistenza di tale potenza, quindi a Mami Wata venne permesso di esistere. La sua forma di donna -pesce potrebbe essere successiva alla sua più antica rappresentazione che non è riportata da alcuna fonte, ma in virtù della sua altra manifestazione il serpente e del suo campo d’azione che è quello delle acque, è stato automatico conferirle tale forma. Suggestiva e fantasiosa è la teoria secondo la quale sia dovuta alla vista delle polene delle navi che sicuramente transitavano ed attraccavano in Africa Occidentale tra il XVI e XIX secolo. Queste solitamente avevano forme femminili e talvolta erano proprio sirene e ciò può aver condizionato l’osservatore e aver creato l’immagine della sua divinità. L’ipotesi che ritengo più verosimile o anche solo più accattivante, ci fa fare un salto indietro nel tempo al 1887, quando la cultura indiana già pubblicizzava in tutto il mondo le sue meraviglie, e in Nigeria apparve il manifesto de The Snake Charmer, lo spettacolo di un’incantatrice di serpenti, Nala Damayanthi; l’artista era circondata di serpenti e abbigliata riccamente: non sarebbe potuta essere che lei il volto della dea! Mami Wata ha la pelle chiara, è “la bianca venuta dal mare”, e una folta chioma scura; in alcune raffigurazioni invece appare con la pelle scura, probabilmente ad immagine e somiglianza della musa dell’artista e quindi si diffonde in entrambe le varianti, senza che questo possa costituire un problema formale. Nala Daayanthi era indiana, ma nata in Francia e questo spiegherebbe anche il perchè Mami Wata nasce come divinità dalla pelle bianca o almeno più chiara rispetto ai suoi adoratori africani. Talvolta si manifesta come completamente umana e molti giurano di averla vista aggirarsi nei mercati, in forma di uomo o di donna, carica di gioielli, per soddisfare la propria vanità; le sue effigi e i suoi altari riflettono questa caratteristica, è infatti raffigurata in modo quasi barocco. Il culto può essere anche collettivo, ma Lei preferisce trattare con i propri fedeli singolarmente: ha una corte di adepte chiamate Mamissi che in alcuni periodi dell’anno portano collane al mare per purificarle in acqua e trasmettere la loro carica positiva alle proprietarie. I devoti indossano abiti bianchi e rossi a sottolineare la spiccata natura duale della dea, maschio e femmina, benevola e capricciosa, dea della fertilità e dispensatrice di morte. La danza sfrenata fa parte del rito; adora ricevere doni preziosi, cibi e bevande ed è circa mezzo secolo che la Coca Cola è entrata a far parte della ritualità ufficiale di questa ed altre divinità. La sessualità è una prerogativa fissa di Mami Wata, tanto nel versante africano che in quello americano, ma non soltanto dal punto di vista fisico perché ciò a cui lei ambisce nel rapporto con i suoi adepti, sono fedeltà e discrezione, infatti impone che essi non parlino con gli altri dei loro incontri e in cambio concede ricchezza e felicità. Mami Wata concede anche la guarigione dai malanni più vari e da gravi patologie e viene spesso incolpata di questo genere di problemi di salute, ma ha a cuore chi si cura del suo culto e si prodiga per il benessere degli umani. Mami Wata subisce vessazioni anche in epoca moderna, viene infatti, con mia enorme sorpresa, ancora demonizzata e i suoi adepti osteggiati in un ritrovato fervore antivoodoo, inaspettatamente in ambito europeo, incolpando velatamene il culto di incentivare la prostituzione.‘

Sirene, sirene, sirene… Ogni mare, ogni oceano sembra dunque ospitare queste creature affascinanti e imprevedibili. O perlomeno così raccontano le leggende e i miti del mondo intero. Ma quanto ci sarà di vero in queste storie? Possibile che esistano effettivamente donne bellissime dalla coda di pesce capaci di incantare gli uomini col suono melodioso della loro voce? Cristoforo Colombo asserì di aver avvistato, nel 1493, degli esseri pesciformi, ma dal volto maschile. Ma se l’esploratore genovese fu il primo ad affermare di averle viste, non rimase a lungo l’unico. Nel 1608 alcuni membri dell’equipaggio del navigatore Henry Hudson si dissero sicuri di aver avvistato una sirena dalla pelle chiara e dai capelli neri, anche se non si conosce con certezza il punto esatto in cui la creatura si mostrò ai marinai. Nel 1881 un pescatore vide (o così raccontò) di averne avvistata una per ben cinque volte nel fiume Susquehanna, in Pennsylvania. Altri due resoconti provenienti dal Canada parlano di due avvistamenti avvenuti a un secolo di distanza l’uno dall’altro. Pare inoltre che nell’Europa rinascimentale ogni corte possedesse una Wunderkammer, ossia una “Camera delle Meraviglie”, dove venivano collocati reperti archeologici, antichità e animali fantastici mummificati; ebbene, tra questi ultimi aveva naturalmente il suo posto d’onore la sirena. Il suo aspetto, in verità, non era particolarmente attraente. Le sirene mummificate apparivano più come piccoli alieni con le pinne che come fanciulle dai lunghi capelli e una coda di pesce. Il motivo della loro scarsa avvenenza? Presto detto: si trattava, niente di più, niente di meno, di raiformi (comunemente chiamate razze) imbalsamati in maniera fantasiosa e creativa per dar loro una vaga sembianza umanoide. Delle falsificazioni, in definitiva, quelle che oggi in romanesco vengono dette “sòle”.

Ma le sirene, quindi, esistono oppure no? Lasciando da parte i poveri pesci imbalsamati spacciati per sirene, che cosa dobbiamo pensare degli avvistamenti registrati nel corso dei secoli? Secondo gli scienziati, non c’è alcuna prova della loro esistenza. Chi raccontò di averle viste probabilmente era in buona fede, sinceramente convinto di aver avuto un incontro ravvicinato con queste fantastiche creature degli abissi; è molto più probabile, però, che si trattasse di dugonghi o di lamantini, il cui corpo può effettivamente essere scambiato, soprattutto se visto da una grande distanza, per quello di una sirena. Esiste poi, sempre secondo gli scienziati, un paradosso imprescindibile che riguarda la figura della sirena: essa viene sempre rappresentata, dai fianchi in su, come una donna, dotata di seno e di ombelico; tuttavia, se la parte inferiore del suo corpo è simile a quella di un pesce (il che la rende un non-mammifero), che senso avrebbero seno e ombelico, funzionali esclusivamente per i mammiferi?

Sirena
Sono convinto che tu non esista
e tuttavia ogni notte ti ascolto
t’invento a volte con la vanità
con la desolazione o la pigrizia.
Dall’infinito mare arriva il tuo stupore
l’ascolto come un salmo e ciò malgrado
son così certo che tu non esista
che ti aspetto nel sogno per domani.
Mario Benedetti (1920-2009)

Letture consigliate
Skye Alexander: “Sirene”
Doreen Virtue: “Sirene e delfini”
Doreen Virtue: “Messaggi dalle sirene”
Doreen Virtue: “ABC delle sirene”
Pietro Alligo: “I Tarocchi delle sirene”

*Citazione da Giuseppe Tomasi di Lampedusa: La sirena, (originariamente Lighea), Milano, Feltrinelli, 2014